A. Munro - La vista da Castle rock
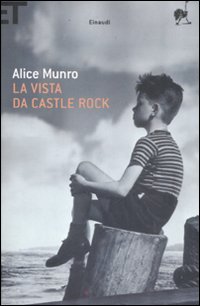
Recensione:
Luciana Tufani Editrice - Leggere Donna (n. 142)
settembre-ottobre 2009
L’uso sapiente dei racconti, raccolti insieme a formare una catena di storie, di ricordi e di avventure umane, legati dal filo conduttore di una affascinante saga familiare, ha consentito ad Alice Munro di produrre questo originale libro di memorie, quasi un romanzo a episodi, tra loro strettamente connessi, anche se lontani nello spazio e nel tempo.
Due sono i filoni principali che vi si possono individuare; nella prima parte la storia della famiglia dagli inizi del diciannovesimo secolo fino allo scoppio della grande Guerra, nella seconda la narrazione autobiografica che vede protagonista l’autrice dall’infanzia alla maturità.
Si avverte tra le due parti una leggera frattura, ma la narrazione fluida e coinvolgente permette al lettore di superare agevolmente l’iniziale perplessità nel passare da una vicenda all’altra.
Attraverso le vicissitudini dei Laidlaw, suoi antenati emigrati in Canada dalla Scozia ai primi dell’800, la Munro rievoca la storia di questo grande paese, costruito grazie alla sofferenza e alla fatica dei tanti che come loro attraversarono l’oceano su precarie imbarcazioni, patendo il mare, la paura e la promiscuità, alla ricerca di condizioni di vita migliori e di libertà di pensiero e di religione. Una volta sbarcati trovarono un territorio sconfinato ed ostile, inverni terribili da affrontare anche per dei gagliardi scozzesi abituati al clima umido e freddo delle Highlands, ma anche potenzialità nuove e liberatorie. Qualcuno seppe coglierle, altri rimasero schiacciati da questo nuovo mondo che non riuscirono ad affrontare e come al solito particolarmente dura fu la vita di donne e bambini, i più esposti in un ambiente difficile.
Con l’abilità descrittiva che la distingue, la Munro ci offre un quadro vivido e affascinante della nascita del Canada, dall’epopea pionieristica dei cacciatori di pellicce e dei contadini che dissodavano a braccia acri e acri di terra, fino allo sviluppo della ferrovia e dell’edilizia ai primi del ‘900.
Parla del suo paese, il paese che ama pur nelle sue molte contraddizioni, e riesce a comunicarci questo vibrante sentimento in quella che è, a mio parere, la parte più interessante del libro. Ci descrive paesaggi fiabeschi, foreste sterminate e tempeste di neve, il gelo che penetra nelle case mal riscaldate, ma anche il fascino dei meli in fiore, l’occhio luminoso delle volpi, i prati ricoperti di asfodeli e poi la semplicità della vita, la povertà diffusa in questa nazione che oggi é divenuta sinonimo di benessere, comodità, lavoro per tutti.
Gli ultimi capitoli compongono invece un memoir, attraverso cui l’autrice presenta se stessa bambina, la sua infanzia in campagna, la vita modesta delle fattorie sperse nel grande nord, dove fino agli anni ’50 non arrivava la corrente elettrica e le dure regole di una società maschilista che apprezzava sopra tutto la forza fisica condizionavano l’esistenza di chiunque fosse diverso.
Vediamo Alice crescere, sposarsi, ricordare le persone che hanno fatto parte della sua esistenza, ricreate con una abilità e una sensibilità che le sono valsi prestigiosi premi letterari canadesi e l’approvazione di importanti critici di altri paesi, come Pietro Citati che ha usato l’espressione bello come un racconto della Munro.
C’é in effetti in queste pagine una sottile maestria; l’autrice riesce a far tornare tra noi con la magia della scrittura le persone scomparse che le furono care, restituendo così alla parola la sua funzione principale, quella appunto di strapparle all’oblio e alla morte. Forse, ed é l’unico appunto, troppi personaggi di cui a volte non ci viene detto abbastanza.
Allo stesso modo davanti ai nostri occhi riappaiono l’ambiente e il paesaggio di un paese ormai cambiato per sempre, ricostruito e vezzeggiato nel pensiero con infinita nostalgia. Rimpianto della giovinezza, o di una vita ormai quasi tutta dietro le spalle, vissuta intensamente, ma forse non ancora abbastanza?
Le rimozioni di tanti recinti e frutteti e case e fienili, a me sembra aver avuto l’effetto di ridurre alla vista le dimensioni del paesaggio, anziché d’ingrandirlo. Tutti quei pioli, il filo spinato, le siepi e i paraventi, quei filari di piante fronzute, l’uso variegato degli appezzamenti di terra, quei tipici grappoli di case abitate con i granai e gli altri edifici di servizio annessi, circa ogni quarto di miglio, tutta quell’organizzazione e quella cura destinate a esistenze note e al tempo stesso segrete, facevano apparire significativo ogni angolo di steccato, ogni ansa del torrente.
Come se allora fosse possibile vedere di più, anche se adesso si vede più lontano.