Herta Müller, L’altalena del respiro
05/novembre/2011
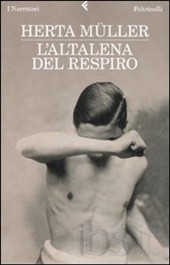
Recensione: Luciana Tufani Editrice - Leggere Donna (n. 153)
ott-dic 2011
Herta Müller, premio Nobel per la letteratura 2009, é nata nel 1953 in un villaggio del Banato Rumeno, all’interno della minoranza tedesca che da circa duecento anni vive in quella zona. Sono per noi luoghi lontani e ben poco sappiamo delle vicissitudini che nel secolo scorso li hanno travolti e squassati.
Tra i tanti meriti di questo libro, un testo importante, ricco di pathos e di creatività, c’é quindi anche quello di aver raccontato al pubblico europeo un episodio della nostra storia che in molti ignoravamo. Il tragico destino di questa minoranza é stato finalmente portato alla ribalta.
La storia inizia nel 1945, quando i campi di concentramento tedeschi furono liberati, ma altri campi aprirono. In Unione Sovietica. I Russi, nuovi alleati di Bucarest, chiesero che tutte le popolazioni che avevano avuto rapporti con i nazisti fossero deportate. Fra loro la popolazione germanofona della Transilvania.
Mentre dappertutto in Europa i prigionieri rientravano a casa, in Romania le cose andavano diversamente: il governo sovietico decise che tutti i cittadini rumeni di origine tedesca fossero arrestati. C’erano stati, é vero, tra loro dei collaborazionisti, ma l’ordine fu che ogni persona di età compresa tra i 17 e i 45 anni venisse deportata in un campo di lavoro, uomo o donna, collaborazionista o no.
Anche la madre della Müller, come racconta lei stessa nella postfazione, era stata vittima della deportazione, ma fu solo parlando con l’amico poeta e traduttore Oskar Pastior, che aveva subito da ragazzo lo stesso destino, che l’autrice decise di approfondire la conoscenza dell’argomento, con l’idea di scrivere in seguito un libro a quattro mani.
Da bambina “il tema della deportazione era tabù, perchè ricordava il passato fascista della Romania. Solo in famiglia e con gli amici intimi i quali erano stati anch’essi deportati si parlava degli anni del lager. E anche allora soltanto per allusioni. Queste conversazioni furtive hanno accompagnato la mia infanzia.:
Purtroppo Pastior morì prima della stesura del testo. Dolorosamente il “noi” si tramutò in un “io” narrante, impersonato dal giovane Leopold, un diciassettenne di campagna costretto dai soldati russi a salire con i compaesani su un convoglio ferroviario diretto al gulag.
La sua valigia è la vecchia custodia di un grammofono; al suo interno qualche libro, pochi vestiti caldi, piccoli oggetti di toilette. Tutto durerà poco, nel gelo siberiano che per cinque anni devasterà il corpo e la mente di Leo.
La fatica e la fame, onnipresenti nel lager, abbrutiscono gli uomini fino all’estremo: “la mia avidità é rozza, le mie mani selvagge. Sono le mie mani, l’angelo della fame non tocca la spazzatura...la fame non é il telaio di un letto, la fame non é un oggetto, altrimenti avrebbe una misura.”
In brevi, scarni capitoli, Herta Müller ci trasmette la voce di Leo. La vita quotidiana prende forma attraverso parole semplici, parole di tutti i giorni. Eppure lo stile sale con lo scorrere delle pagine e si fa duro, potente e vibrante nel comunicarci lo sfinimento e la fatica dell’uomo: “ Quando la carne è sparita portare le proprie ossa diviene un fardello che schiaccia al suolo”
Leo riesce a resistere, sostenuto dalla voce della nonna che sulla soglia di casa, al momento della partenza gli ha sussurrato: “Io so che ritornerai”. O forse solo dal suo istinto primordiale di giovane animale che anela alla sopravvivenza.
Dopo quasi cinque anni finalmente può rientrare a casa, ma troppo lunga e straziante per non lasciare tracce é stata la permanenza nel lager.
Il ritorno é anch’esso sofferenza; nei pensieri, nei sogni è come se egli fosse ancora lì, a lottare ogni giorno contro la morte. Il lager l’ha lasciato uscire solo per stabilire la distanza di cui ha bisogno per stabilirsi nella sua mente. “Sempre più il lager si stende dal lobo temporale sinistro a quello destro...Sui miei tesori c’è scritto DI LA’ NON VENGO VIA”
Il dramma dei sopravvissuti, incapaci di reintegrarsi nel mondo di chi non ha conosciuto l’orrore, già così bene spiegato nelle pagine di Primo Levi e di altra letteratura concentrazionaria, emerge chiaro nelle ultime pagine del libro. È un monito a non dimenticare che possono cambiare i carnefici, ma non la sofferenza delle vittime né la vergogna che ci coinvolge tutti nella nostra umanità.
“La grande défaite en tout c’est d’oublier” scrisse Celine, e questa colpa la Muller la rigetta. Bisogna conoscere, per poter giudicare.
I fatti quindi sono portati a conoscenza del lettore con uno stile che coniuga realismo e onirismo, gli oggetti del quotidiano sono personificati, i dettagli crudi si intrecciano alle immagini poetiche. Sono questa alleanza e questo contrasto che danno energia al romanzo, un’opera forte e a tratti sconvolgente con cui l’autrice conferma le sue indubbie qualità di narratrice.